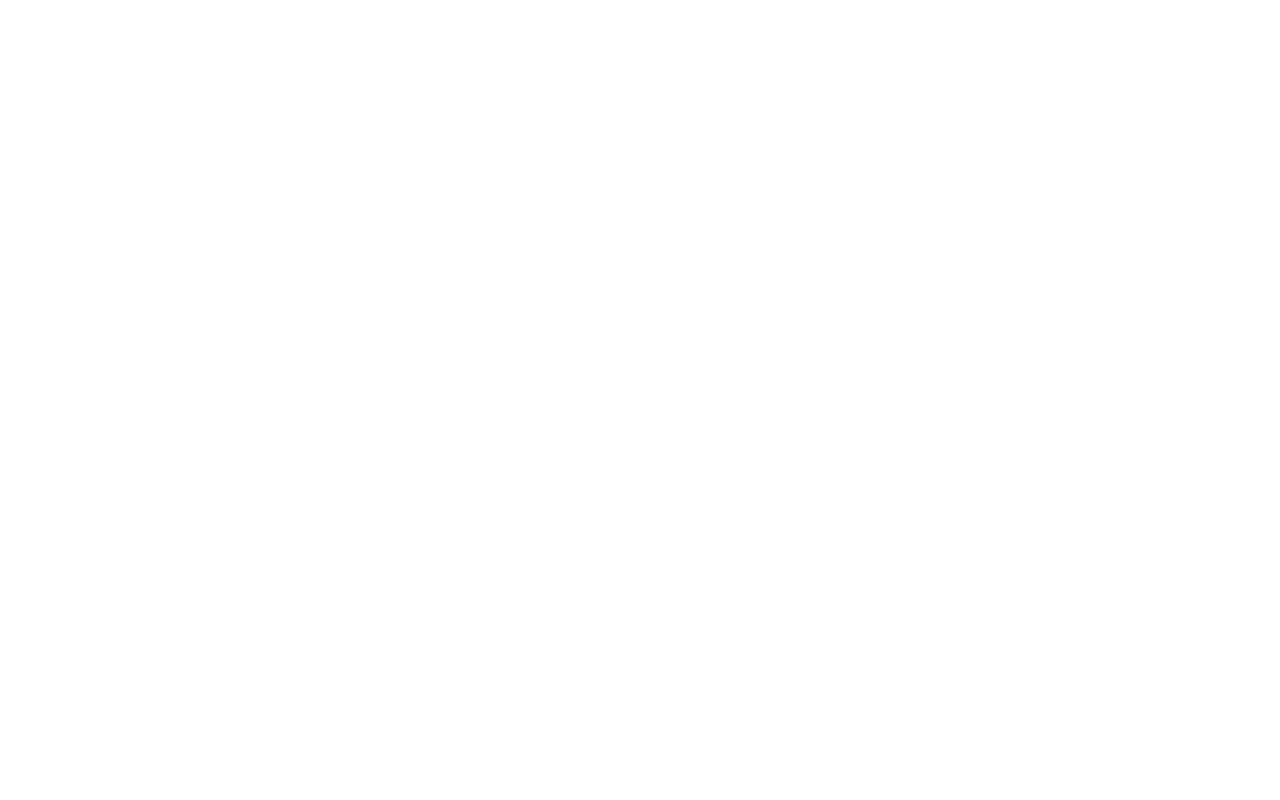STORIA DELL'ARCHITETTURA
HISTORY OF ARCHITECTURE
| A.A. | CFU |
|---|---|
| 2024/2025 | 9 |
| Docente | Ricevimento studentesse e studenti | |
|---|---|---|
| Alessandra Cattaneo | Si riceve al termine delle lezioni previo appuntamento. Per la richiesta inviare una mail all'indirizzo:alessandra.cattaneo@uniurb.it |
| Didattica in lingue straniere |
|---|
|
Insegnamento con materiali opzionali in lingua straniera
Inglese
La didattica è svolta interamente in lingua italiana. I materiali di studio e l'esame possono essere in lingua straniera. |
Assegnato al Corso di Studio
| Giorno | Orario | Aula |
|---|
| Giorno | Orario | Aula |
|---|
Obiettivi Formativi
Gli obiettivi che s'intende perseguire sono principalmente quelli del raggiungimento, da parte di studentesse e studenti, di un buon livello di conoscenza, relativa alla comprensione storico-critica dei caratteri stilistici e costruttivi dell'architettura di ogni periodo storico; dalla classicità greca fino al XX secolo.
Il corso è articolato secondo due direttrici; una teorico-metodologica (lezioni ex cathedra) e una applicativa, svolta con delle esercitazioni pratiche, relative alla lettura - attraverso l'osservazione diretta - di alcuni edifici della realtà urbinate. Ci si propone così, di fornire gli strumenti necessari per una corretta interpretazione - degli aspetti storico/costruttivi - dell'opera architettonica nel suo insieme e nelle parti che la compongono. Verranno illustrate, in sintesi, le più importanti tematiche relative al linguaggio dell'architettura nei suoi aspetti costruttivi ed espressivi (analisi delle strutture, metrologia e proporzionamento, morfologia e sintassi del linguaggio architettonico). Una conoscenza, questa, finalizzata alla corretta applicazione delle operazioni di conservazione e restauro.
Programma
1. Introduzione allo studio della storia dell'architettura
- Indicazioni di metodo per una corretta ricerca storica
2. Le strutture murarie antiche
- Strutture megalitiche; strutture poligonali
- Strutture greche in pietra squadrata. Taglio, lavorazione, posa in opera dei blocchi; trasporto e sollevamento. Perni e grappe.
- Strutture murarie romane: opus quadratum, opus caementicium, opus africanum, opus incertum, opus reticulatum, opus vittatum. I laterizi romani; opus testaceum e opus mixtum.
- Gli studi metrologici ai fini della storia dell'architettura
3. Gli ordini architettonici
- Il linguaggio degli ordini morfologia e sintassi
4. L'architettura greca
- Nascita e sviluppo dell'architettura della città greca
- L'architettura civile
5. L'architettura romana
- Il periodo repubblicano
- Il periodo imperiale
- La lettura delle strutture antiche
6. L'architettura tardoantica e paleocristiana
- Caratteri dei sistemi costruttivi
- Le prime basiliche costantiniane
7. L'architettura romanica
- Caratteri dei sistemi costruttivi
- Le grandi abbazie
8. Il periodo dell'architettura gotica
- Caratteri dei sistemi costruttivi
- Alcuni esempi in Italia e in Europa
9. L'architettura del Quattrocento
- Il rinascimento: caratteri generali
- L'età umanistica e la rinascita dell'antico:Filippo Brunelleschi
10. L'architettura del Cinquecento
- I principali protagonisti: Bramante, Michelangelo, Giulio Romano, Palladio, Vignola
- Il Manierismo
11. L'architettura del primo Seicento
- Caratteri generali del Barocco
- I protagonisti: Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, Pietro da Cortona
12. Il Neoclassicismo
- Le trasformazioni culturali: l'architettura neoclassica
- Il Neoclassicismo in Italia
13. L'Ottocento in Europa
- L'architettura del ferro e le nuove spazialità
- Il Neomedievalismo e la figura di E. Viollet Le Duc
- Il romanticismo inglese: W. Morris e J. Ruskin
- L'art Nouveau
- L'eclettismo
14. Il XX secolo
- Il mito della prateria: Frank Lloyd Wright
- W. Gropius e il Bauhaus
- Il movimento moderno
- Le Corbusier
- Mies van de Rohe
- L'architettura civile e religiosa di Glauco Gresleri in Italia
Eventuali Propedeuticità
Nessuna
Risultati di Apprendimento (Descrittori di Dublino)
Gli studenti e le studentesse verranno valutati/e:
1) sulla capacità acquisita di riuscire a esprimere un giudizio critico autonomo, fondato su solide basi scientifiche, in merito alla lettura delle architetture;
2) sulla capacità di apprendere e comprendere le nozioni della disciplina della storia dell'architettura al fine di farle diventare parte del proprio bagaglio culturale;
3) sulla capacità di saper raccogliere, sintetizzare e interpretare scientificamente i dati raccolti inerenti lo studio di un'architettura;
4) sull'abilità comunicativa nell'esprimere con terminologia appropriata il proprio pensiero;
5) sulla capacità di riuscire a restituire graficamente una lettura critica e diretta delle architetture oggetti di studio.
Materiale Didattico
Il materiale didattico predisposto dalla/dal docente in aggiunta ai testi consigliati (come ad esempio diapositive, dispense, esercizi, bibliografia) e le comunicazioni della/del docente specifiche per l'insegnamento sono reperibili all'interno della piattaforma Moodle › blended.uniurb.it
Attività di Supporto
Durante lo svolgimento delle lezioni verranno distribuite dispense e materiale didattico in formato elettronico.
Inoltre, saranno fornite indicazioni bibliografiche sugli specifici argomenti trattati per eventuali approfondimenti.
Insieme agli allievi/e saranno concordate eventuali visite ai monumenti di Urbino utili per verificare insieme le conoscenze acquisite.
Il materiale didattico e le comunicazioni specifiche della docente sono reperibili, assieme ad altre attività di supporto, all'interno della piattaforma Moodle> blended.uniurb.it
Modalità Didattiche, Obblighi, Testi di Studio e Modalità di Accertamento
- Modalità didattiche
Il corso si svolge mediante lezioni frontali.
Le lezioni in aula si svolgeranno con l'ausilio di immagini in Power Point, reperibili, assieme ad altro materiale di supporto, sulla piattaforma Moodle> blended.uniurb.it
- Didattica innovativa
Il corso prevede:
- lezioni frontali della docente;
- lavori di gruppo o singoli con produzione di elaborati scritti; presentazioni orali dei lavori;
- lezioni partecipate nelle quali verranno discussi i lavori presentati.
- Obblighi
Al fine del superamento dell'esame è obbligatorio, per ogni allieva/o, redigere una tesina (che rispetterà le norme redazionali date dalla docente) che riguarderà l’analisi storico - critica di una architettura, la cui scelta sarà concordata con la docente. Inoltre, l'allieva/o dovrà preparare per la discussione orale una presentazione in PowerPoint sull'argomento trattato nella tesina (durata massima della presentazione 15 minuti).
La tesina e la presentazione andranno consegnate alla docente in formato digitale (.pdf e .doc) almeno 10 giorni prima dell'esame. Invece, il giorno stesso dell'esame l'allieva/o dovrà consegnare la tesina in formato cartaceo.E' gradita la frequenza delle lezioni.
- Testi di studio
Testi di riferimento:
- D. Watkin, Storia dell'architettura occidentale, Zanichelli, Bologna, 1990 (o ed. successive), pp. 3 - 108; pp. 118 - 156; pp. 158 - 167; pp. 170 - 177; pp. 185 - 223; pp. 253 - 288; pp. 375 - 382; pp. 417 - 444; pp. 456 - 463; pp. 488 - 497; pp. 535 - 543; pp. 559 - 578; pp. 602 -609; pp. 620 - 625; pp. 661 - 669.
- A. Cattaneo, Tutela, valorizzazione e manutenzione delle "città morte", Tab, Roma, 2020, pp. 192-215; 236-249; 262-302; 312-322; 339-363.
Testi di approfondimento:
- C. Bozzoni, V. Franchetti Pardo, G. Ortolani, A. Viscogliosi,, L’architettura del mondo antico, Laterza, Roma-Bari, 2006.
- A. Bruschi, G. Miarelli Mariani, Lineamenti di storia dell'architettura, Sovera, Roma, 8a edizione 2006.
- K. Frampton, Storia dell'architettura moderna, Zanichelli, Bologna, 4a edizione, 2008, pp. 2 - 10; pp. 22 - 36; pp. 38 - 48; pp. 56 - 75; pp. 96 - 101; pp. 108 - 127; pp. 136 - 144; pp. 160 - 190; pp. 205 - 222; pp. 237 - 246; pp. 264 - 281.
- P. Gros, L' architettura romana. Dagli inizi del III secolo a. C. alla fine dell'alto impero. I monumenti pubblici, Longanesi, Milano, 2001.
- Alessandra Muntoni, Lineamenti di storia dell’architettura contemporanea, Roma-Bari, Laterza, 1997, 2013, 7a edizione.
- Paolo Portoghesi, Dopo l’architettura moderna, Roma-Bari, Laterza, 1980.
- R. Wittkower, Principi architettonici nell’età dell’Umanesimo, introduzione di Richard Krautheimer, traduzione di Renato Pedio, Torino, Einaudi, 1964, 2007, 7a edizione (ed. originale: Architectural Principles in the Age of Humanism, The Warburg Institute, London, 1949).
Ulteriori riferimenti bibliografici, relativi ai diversi argomenti trattati, saranno suggeriti nel corso delle lezioni.
- Modalità di
accertamento La verifica dei risultati raggiunti dagli studenti e dalle studentesse sarà condotta alla fine del semestre mediante esame individuale.
Dopo l'illustrazione della tesina, che riguarderà l'analisi storico-critica di un'architettura scelta dallo studente o dalla studentessa in accordo con la docente, si passerà ad un colloquio sui temi trattati nelle lezioni e nella bibliografia di base.
l criteri di valutazione per la tesina sono: la capacità di saper applicare un metodo per lo studio di un'architettura; la capacità di saper esprimere un giudizio critico. Alla tesina verranno attribuiti i due terzi della valutazione in trentesimi.
l criteri di valutazione per la discussione orale sono: il livello di padronanza degli argomenti trattati; il grado di articolazione delle risposte. Alla discussione orale verrà attribuito un terzo della valutazione in trentesimi.
- Disabilità e DSA
Le studentesse e gli studenti che hanno registrato la certificazione di disabilità o la certificazione di DSA presso l'Ufficio Inclusione e diritto allo studio, possono chiedere di utilizzare le mappe concettuali (per parole chiave) durante la prova di esame.
A tal fine, è necessario inviare le mappe, due settimane prima dell’appello di esame, alla o al docente del corso, che ne verificherà la coerenza con le indicazioni delle linee guida di ateneo e potrà chiederne la modifica.
Informazioni aggiuntive per studentesse e studenti non Frequentanti
- Modalità didattiche
Studio individuale.
- Obblighi
Gli studenti e le studentesse non frequentanti dovranno studiare individualmente sui testi di riferimento con l'aggiunta di un ulteriore testo a scelta tra quelli indicati dalla docente.
Al fine del superamento dell'esame è obbligatorio, per ogni allieva/o, redigere una tesina (che rispetterà le norme redazionali date dalla docente) che riguarderà l’analisi storico - critica di una architettura, la cui scelta sarà concordata con la docente. Inoltre, l'allieva/o dovrà preparare per la discussione orale una presentazione in PowerPoint sull'argomento trattato nella tesina (durata massima della presentazione 15 minuti).
La tesina e la presentazione andranno consegnate alla docente in formato digitale (.pdf e .doc) almeno 10 giorni prima dell'esame. Invece, il giorno stesso dell'esame l'allieva/o dovrà consegnare la tesina in formato cartaceo.
- Testi di studio
Testi di riferimento:
- D. Watkin, Storia dell'architettura occidentale, Zanichelli, Bologna, 1990 (o ed. successive), pp. 3 - 108; pp. 118 - 156; pp. 158 - 167; pp. 170 - 177; pp. 185 - 223; pp. 253 - 288; pp. 375 - 382; pp. 417 - 444; pp. 456 - 463; pp. 488 - 497; pp. 535 - 543; pp. 559 - 578; pp. 602 -609; pp. 620 - 625; pp. 661 - 669.
- A. Cattaneo, Tutela, valorizzazione e manutenzione delle "città morte", Tab, Roma, 2020, pp. 192-215; 236-249; 262-302; 312-322; 339-363.
- K. Frampton, Storia dell'architettura moderna, Zanichelli, Bologna, 4a edizione, 2008, pp. 2 - 10; pp. 22 - 36; pp. 38 - 48; pp. 56 - 75; pp. 96 - 101; pp. 108 - 127; pp. 136 - 144; pp. 160 - 190; pp. 205 - 222; pp. 237 - 246; pp. 264 - 281.
Gli studenti e le studentesse non frequentanti, oltre ai testi obbligatori sopra elencati, sono tenuti/e allo studio di un testo a scelta tra quelli indicati qui di seguito:
- C. Bozzoni, V. Franchetti Pardo, G. Ortolani, A. Viscogliosi,, L’architettura del mondo antico, Laterza, Roma-Bari, 2006.
- A. Bruschi, G. Miarelli Mariani, Lineamenti di storia dell'architettura, Sovera, Roma, 8a edizione 2006.
- P. Gros, L' architettura romana. Dagli inizi del III secolo a. C. alla fine dell'alto impero. I monumenti pubblici, Longanesi, Milano, 2001.
- Alessandra Muntoni, Lineamenti di storia dell’architettura contemporanea, Roma-Bari, Laterza, 1997, 2013, 7a edizione.
- Paolo Portoghesi, Dopo l’architettura moderna, Roma-Bari, Laterza, 1980.
- R. Wittkower, Principi architettonici nell’età dell’Umanesimo, introduzione di Richard Krautheimer, traduzione di Renato Pedio, Torino, Einaudi, 1964, 2007, 7a edizione (ed. originale: Architectural Principles in the Age of Humanism, The Warburg Institute, London, 1949).
- Modalità di
accertamento La verifica dei risultati raggiunti dagli studenti e dalle studentesse sarà condotta alla fine del semestre mediante esame individuale.
Dopo l'illustrazione della tesina, che riguarderà l'analisi storico-critica di un'architettura scelta dallo studente o dalla studentessa in accordo con la docente, si passerà ad un colloquio sui temi trattati nel programma del corso e nella bibliografia di base.
l criteri di valutazione per la tesina sono: la capacità di saper applicare un metodo per lo studio di un'architettura; la capacità di saper esprimere un giudizio critico. Alla tesina verranno attribuiti i due terzi della valutazione in trentesimi.
l criteri di valutazione per la discussione orale sono: il livello di padronanza degli argomenti trattati; il grado di articolazione delle risposte. Alla discussione orale verrà attribuito un terzo della valutazione in trentesimi.
- Disabilità e DSA
Le studentesse e gli studenti che hanno registrato la certificazione di disabilità o la certificazione di DSA presso l'Ufficio Inclusione e diritto allo studio, possono chiedere di utilizzare le mappe concettuali (per parole chiave) durante la prova di esame.
A tal fine, è necessario inviare le mappe, due settimane prima dell’appello di esame, alla o al docente del corso, che ne verificherà la coerenza con le indicazioni delle linee guida di ateneo e potrà chiederne la modifica.
| « torna indietro | Ultimo aggiornamento: 28/01/2025 |