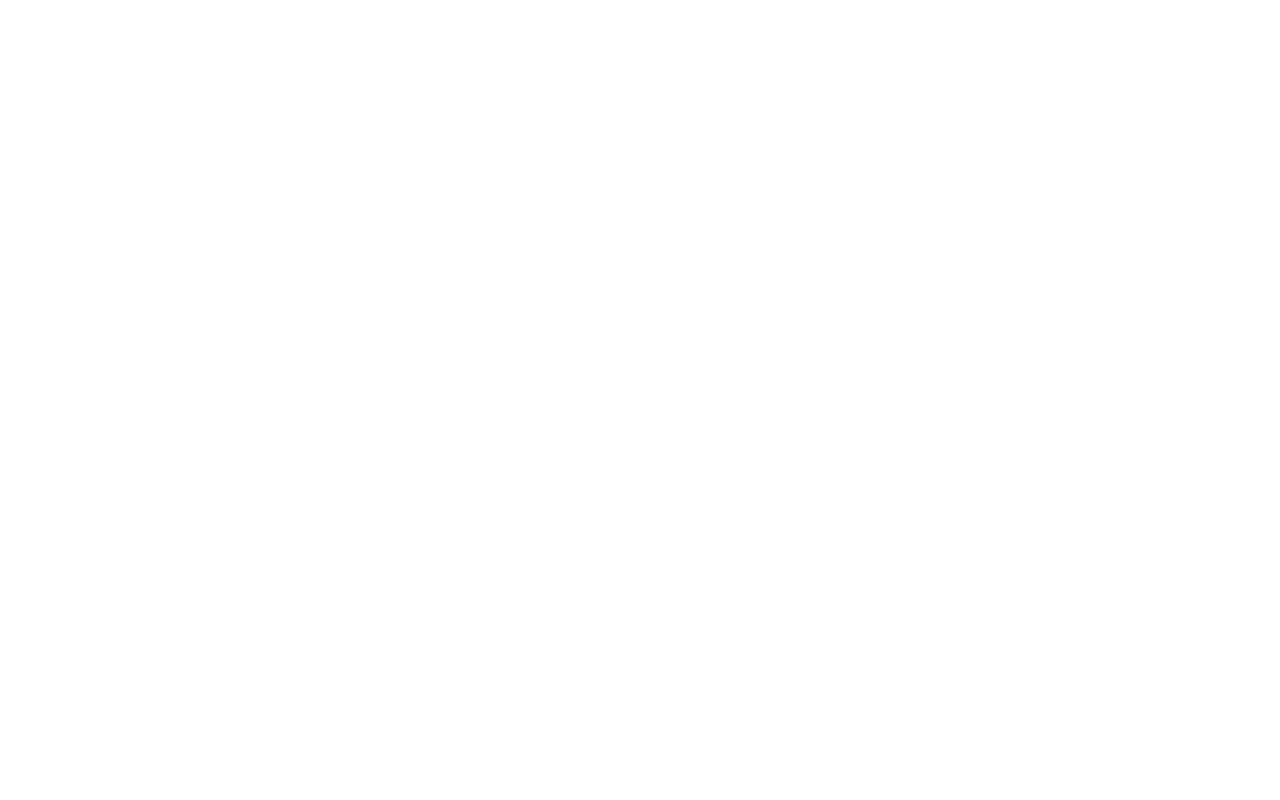CHIMICA ORGANICA II
ORGANIC CHEMISTRY II
| A.A. | CFU |
|---|---|
| 2025/2026 | 6 |
| Docente | Ricevimento studentesse e studenti | |
|---|---|---|
| Francesca Bartoccini | In ogni momento previo avviso per email |
| Didattica in lingue straniere |
|---|
|
Insegnamento con materiali opzionali in lingua straniera
Inglese
La didattica è svolta interamente in lingua italiana. I materiali di studio e l'esame possono essere in lingua straniera. |
Assegnato al Corso di Studio
| Giorno | Orario | Aula |
|---|
| Giorno | Orario | Aula |
|---|
Obiettivi Formativi
L'insegnamento si prefigge di fornire a studentesse e studenti una più approfondita formazione di Chimica Organica rispetto ai primi corsi di base. In particolare il corso è mirato a fornire a studentesse e studenti gli strumenti teorici e logici per considerare le relazioni che intercorrono tra i differenti metodi spettroscopici utilizzati per l'identificazione strutturale dei composti organici e come questi possano essere utilizzati in combinazione per assegnare la struttura a composti ignoti. Studentesse e studenti acquisiranno inoltre conoscenze sulle reazioni pericicliche, reazioni di riarrangiamneto, reazioni radicaliche, reazioni di carbeni e nitreni, formazione di legami carbonio-carbonio e sui principi fondamentali della reattività e della sintesi asimmetrica organica inclusi primi accenni di organocatalisi, imparando a sviluppare semplici sequenze sintetiche di composti organici polifunzionali e ad applicare i principi delle moderne strategie sintetiche. Inoltre, verranno introdotte e approfondite alcune importanti relazioni tra la chimica organica e la chimica biologica, con particolare attenzione ai meccanismi molecolari coinvolti nei processi biologici e ad alcune vie biosintetiche fondamentali.
Programma
1) Revisione dei metodi spettroscopici
La spettroscopia per distinguere e spiegare la reattività del gruppo carbonilico (C=O) - La spettroscopia per spiegare la reattività e i prodotti di reazione dei composti carbonilici a,b-insaturi - La spettroscopia per spigare la dimensione degli anelli - La spettroscopia per assegnare la struttura di composti sconosciuti
2) Eterocicli saturi ed effetti stereoelettronici
Reazioni degli eterocicli saturi - Conformazione degli eterocicli saturi - Sintetizzare gli eterocicli: reazioni di chiusura di anello (Effetto Thorpe-Ingold – Regole di Baldwin) - Dimensione dell'anello e NMR - Accoppiamento geminale (2J) - Gruppi omotopici, enantiotopici e diastereotopici
3) Stereoselettività
Controllo stereochimico negli anelli a sei membri - Reazioni di anelli piccoli - Controllo stereochimico negli epossidi del cicloesene - Stereoselettività nei composti biciclici (bicicli pontati, biciclici fusi e spirociclici) - Reazioni con intermedi ciclici o con stati di transizione ciclici
4) Diastereoselettività
Prochiralità - Il modello di Felkin–Anh - Reazioni stereoselettive di alcheni - Reazioni aldoliche stereoselettive
5) Reazioni pericicliche 1: cicloaddizioni
La reazione di Diels-Alder - La reazione “ene” di Alder - Cicloaddizioni fotochimiche [2 + 2] - Cicloaddizioni termiche [2 + 2] - Cicloaddizioni 1,3-dipolari
6) Reazioni pericicliche 2: reazioni sigmatropiche ed elettrocicliche
Trasposizione [3,3]-sigmatropiche (Trasposizione di Claisen, Trasposizione di Cope, riarrangiamento di Overman) - Trasposizione [2,3]-sigmatropiche - Shift [1,5]-sigmatropici di idrogeno - Reazioni elettrocicliche (Ciclizzazione di Nazarov)
7) Reazioni di partecipazione, riarrangiamento e frammentazione
Partecipazione dei gruppi vicinali – Il riarrangiamento di Payne - Il riarrangiamento di Wagner–Meerwein - Il riarrangiamento pinacolico - Il riarrangiamento dienone-fenolo - Il riarrangiamento dell'acido benzilico - Il riarrangiamento di Favorskii - La reazione di Baeyer-Villiger - Il riarrangiamento di Beckmann - Espansione dell'anello via frammentazione - La frammentazione di Eschenmoser
8) Reazioni radicaliche
Formazione dei radicali - Radicali stabili - Stabilità dei radicali - Reazioni radicale-radicale (Riduzione di Bouveault-Blanc, reazione pinacolica, reazione di McMurry e reazione aciloinica) - Reazioni radicaliche a catena (clorurazione e bromurazione degli alcani, bromurazione allilica, sostituzione radicale di Br con H, deossigenazione e decarbossilazione di Barton-McCombien) - Formazione di legami carbonio-carbonio con i radicali
9) Sintesi e reazioni dei carbeni e nitreni
Sintesi di esteri metilici da acidi carbossilici con diazometano - Sintesi dei carbeni - Carbeni singoletto e tripletto - Reazione dei carbeni: Inserzione in legami pigreco (ciclopropanazione); inserzione in legami sigma e riarrangiamenti (riarrangiamento di Wolff, omologazione di Arndt-Eistert, omologazione di Corey-Fuchs e omologazione di Seyferth-Gilbert) - Nitreni - Reazioni dei nitreni (riarrangiamento di Curtius e di Hofmann) - Carbenoidi – Reazioni di metatesi
10) Chimica organometallica
Complessi di metalli di transizione - Passaggi fondamentali nelle reazioni catalizzate dai metalli di transizione - Reazione di Heck - Reazioni di Cross-coupling (Reazione di Kumada, di Stille, di Negishi e di Suzuki) - Reazione di Sonogashira - Allilazione di Tsuji-Trost - Amminazione di Buchwald-Hartwig - Ossidazione di Wacker
11) Sintesi asimmetrica
Risoluzione di una miscela racemica - Chiral Pool - Ausiliari chirali - Reagenti chirali - Catalizzatori chirali - Organocatalisi - Biocatalisi
12) Chimica biologica
Acidi nucleici - Amminoacidi e proteine - Carboidrati - Meccanismi in chimica biologica - Prodotti naturali - Biosintesi di alcaloidi, acidi grassi e polichetidi aromatici -Terpeni
Eventuali Propedeuticità
Superamento dell'esame di Fisica con elementi di matematica, Chimica generale ed inorganica e Fondamenti di Chimica organica e di Chimica fisica
Risultati di Apprendimento (Descrittori di Dublino)
- D1 - CONOSCENZA E CAPACITA' DI COMPRENSIONE
Al termine di questa attività formativa, studentesse e studenti dovranno dimostrare di essere in grado di:
1) conoscere in modo approfondito le relazioni struttura-proprietà-reattività delle principali famiglie di composti organici polifunzionali;
2) conoscere i principi che guidano le reazioni organiche e che permettono l'interpretazione razionale dei meccanismi di reazione;
3) conoscere le proprietà chimico-fisiche di molecole organiche polifunzionali per familiarizzare con i composti spesso utilizzati in laboratorio;
4) conoscere la centralità della chimica organica all'interfaccia con la biochimica e la chimica farmaceutica;
5) conoscere i vari metodi di indagine spettroscopica per l'identificazione strutturale dei composti organici.
Queste abilità verranno verificate attraverso una prova scritta e domande orali.
- D2 - CAPACITA' DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE
Al termine di questa attività formativa, studentesse e studenti dovranno dimostrare di essere in grado di:
1) descrivere i meccanismi di reazione in molecole organiche polifunzionali;
2) classificare le trasformazioni organiche sulla base delle interazioni tra i diversi gruppi funzionali presenti in una molecola organica;
3) descrivere la progettazione di trasformazioni organiche necessarie per preparare semplici composti organici;
4) descrivere le più funzionali reazioni di riconoscimento dei principali gruppi funzionali;
Queste abilità verranno valutate attraverso una prova scritta e domande orali.
- D3 - AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
Al termine di questa attività formativa, studentesse e studenti dovranno dimostrare di essere in grado di:
1) acquisire i principi fondamentali della sintesi organica per lo sviluppo di semplici sequenze sintetiche di composti organici polifunzionali;
2) capacità di applicare le conoscenze acquisite e la comprensione dei meccanismi di reazione per risolvere problemi di chimica organica;
3) proporre delle moderne strategie sintetiche per la sintesi di composti organici
4) comparare i dati spettroscopici al fine di determinare le strutture di composti organici ignoti;
Queste abilità verranno verificate sia con la prova scritta che attraverso domande orali mirate di tipo applicativo.
- D4 - ABILITA' COMUNICATIVE
Al termine del corso, studentesse e studenti dovranno dimostrare di essere in grado di comunicare in modo chiaro e con un linguaggio adeguato le nozioni apprese durante il corso.
Queste abilità verranno verificate attraverso la prova orale.
- D5 - CAPACITA' DI APPRENDIMENTO
Al termine di questa attività formativa, studentesse e studenti dovranno dimostrare di essere in grado di reperire e applicare nuove informazioni, rispetto a quelle fornite durante l'attività formativa, necessarie per progettare sintesi di nuove molecole organiche.
Materiale Didattico
Il materiale didattico predisposto dalla/dal docente in aggiunta ai testi consigliati (come ad esempio diapositive, dispense, esercizi, bibliografia) e le comunicazioni della/del docente specifiche per l'insegnamento sono reperibili all'interno della piattaforma Moodle › blended.uniurb.it
Attività di Supporto
Esercizi in classe
Modalità Didattiche, Obblighi, Testi di Studio e Modalità di Accertamento
- Modalità didattiche
Il corso prevede lezioni frontali in cui il docente espone i concetti e propone esercizi pratici per favorirne la comprensione.
Studentesse e studenti possono intervenire alle lezioni per richiedere chiarimenti al docente.
- Didattica innovativa
Problem-based learning.
- Obblighi
Non vi son obblighi di frequenza anche se è fortemente consigliata la presenza.
Sono richieste le conoscenze di base relative alle discipline di chimica, fisica e matematica.
- Testi di studio
Chimica Organica- Clayden, Greeves, Warren - Edizione italiana sulla seconda in lingua inglese - Ed. Piccin. ISBN 978-88-299-3233-7; Code Piccin 0327990
Facoltativo:
Eserciziario di chimica organica. Edizione italiana sulla seconda in lingua inglese di Jonathan Clayden (Autore), di Stuart Warren (Autore) Editore: Piccin-Nuova Libreria ISBN: 8829934879
- Modalità di
accertamento La verifica dell'apprendimento che ha lo scopo di accertare l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità attese avviene attraverso il solo esame finale che consiste in una prova scritta e una prova orale.
La prova scritta consiste nella risoluzione di otto esercizi. Gli esercizi saranno redatti secondo tipologie analoghe agli esercizi svolti in aula dal docente. La valutazione della prova scritta viene formulata in trentesimi e si considererà superata con una votazione minima di 18/30. La durata della prova scritta è di 2 ore.
La prova orale è riservata a studentesse e studenti che hanno superato la prova scritta e conseguito una valutazione minima di 18/30 e sarà centrata su domande oggetto del programma del corso.
Il voto finale, che tiene conto degli esiti della prova scritta e della prova orale, viene erogato in trentesimi e riflette la valutazione complessiva del candidato.
- Disabilità e DSA
Le studentesse e gli studenti che hanno registrato la certificazione di disabilità o la certificazione di DSA presso l'Ufficio Inclusione e diritto allo studio, possono chiedere di utilizzare le mappe concettuali (per parole chiave) durante la prova di esame.
A tal fine, è necessario inviare le mappe, due settimane prima dell’appello di esame, alla o al docente del corso, che ne verificherà la coerenza con le indicazioni delle linee guida di ateneo e potrà chiederne la modifica.
Informazioni aggiuntive per studentesse e studenti non Frequentanti
- Modalità didattiche
Il materiale didattico e le comunicazioni specifiche del docente sono reperibili, assieme ad altre attività di supporto, all'interno della piattaforma Moodle › blended.uniurb.it
- Obblighi
Non vi son obblighi di frequenza anche se è fortemente consigliata la presenza.
Sono richieste le conoscenze di base relative alle discipline di chimica, fisica e matematica.
- Testi di studio
Chimica Organica- Clayden, Greeves, Warren - Edizione italiana sulla seconda in lingua inglese - Ed. Piccin. ISBN 978-88-299-3233-7; Code Piccin 0327990
- Modalità di
accertamento La verifica dell'apprendimento che ha lo scopo di accertare l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità attese avviene attraverso il solo esame finale che consiste in una prova scritta e una prova orale.
La prova scritta consiste nella risoluzione di sei esercizi. Gli esercizi saranno redatti secondo tipologie analoghe agli esercizi svolti in aula dal docente. La valutazione della prova scritta viene formulata in trentesimi e si considererà superata con una votazione minima di 18/30. La durata della prova scritta è di 2 ore.
La prova orale è riservata a studentesse e studenti che hanno superato la prova scritta e conseguito una valutazione minima di 18/30 e sarà centrata su domande oggetto del programma del corso.
Il voto finale, che tiene conto degli esiti della prova scritta e della prova orale, viene erogato in trentesimi e riflette la valutazione complessiva del candidato.
- Disabilità e DSA
Le studentesse e gli studenti che hanno registrato la certificazione di disabilità o la certificazione di DSA presso l'Ufficio Inclusione e diritto allo studio, possono chiedere di utilizzare le mappe concettuali (per parole chiave) durante la prova di esame.
A tal fine, è necessario inviare le mappe, due settimane prima dell’appello di esame, alla o al docente del corso, che ne verificherà la coerenza con le indicazioni delle linee guida di ateneo e potrà chiederne la modifica.
Note
E' fortemente consigliata la frequenza alle lezioni e alle esercitazioni.
| « torna indietro | Ultimo aggiornamento: 04/06/2025 |