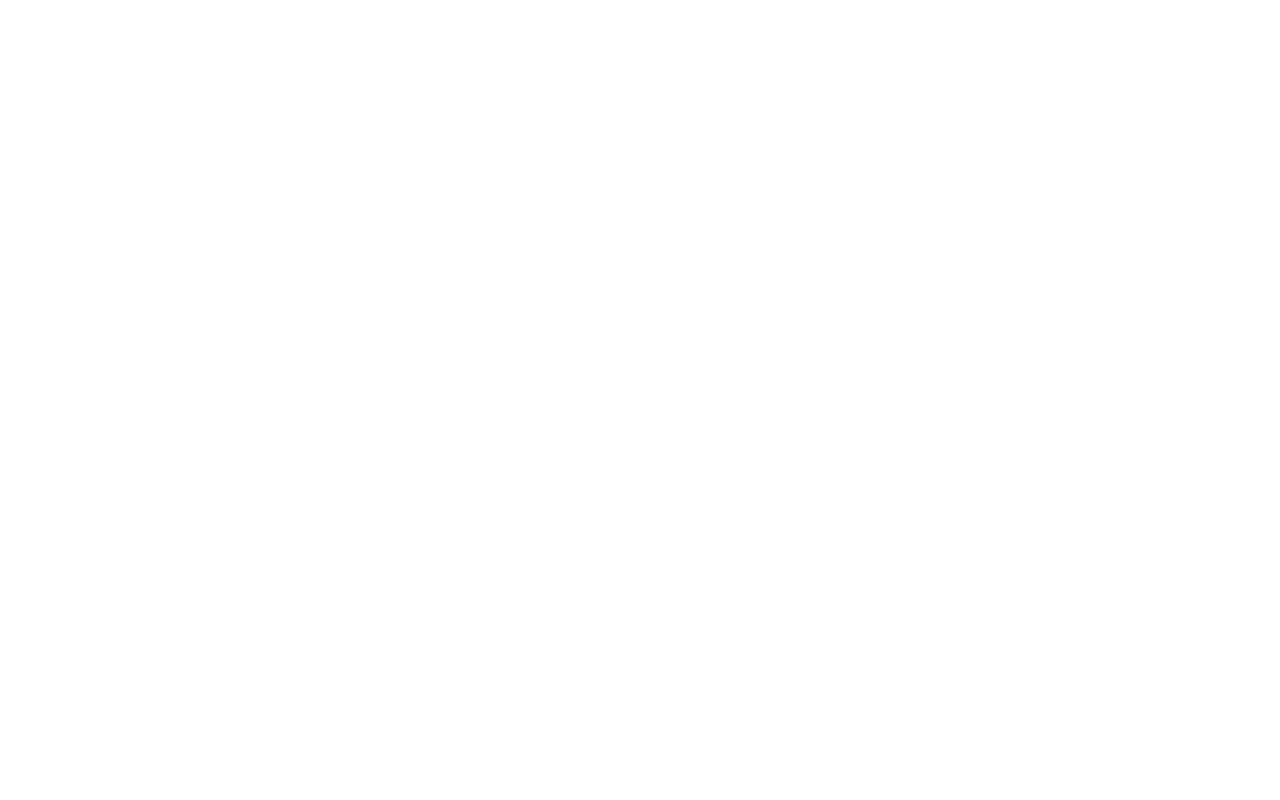SOCIOLINGUISTICA DEI DIALETTI
SOCIOLINGUISTICS OF DIALECTS
| A.A. | CFU |
|---|---|
| 2025/2026 | 6 |
| Docente | Ricevimento studentesse e studenti | |
|---|---|---|
| Duccio Piccardi | Previo appuntamento per email, lunedì, 18-19 (studio del docente, Palazzo Albani) o online. |
| Didattica in lingue straniere |
|---|
|
Insegnamento con materiali opzionali in lingua straniera
Inglese
La didattica è svolta interamente in lingua italiana. I materiali di studio e l'esame possono essere in lingua straniera. |
Assegnato al Corso di Studio
| Giorno | Orario | Aula |
|---|
| Giorno | Orario | Aula |
|---|
Obiettivi Formativi
Il corso mira a dare uno sguardo d'insieme sulla situazione linguistica italiana, con particolare attenzione alla coesistenza dei dialetti con l'italiano e le sue varietà geografiche e alle dinamiche sociali coinvolte nei processi linguistici di variazione e mutamento. A tal fine, il corso propone da una parte una panoramica sulle principali categorie interpretative della sociolinguistica della variazione, dando rilievo al tema dello spazio e del luogo e prediligendo, laddove possibile, esempi presi dalla letteratura su fenomeni linguistici italiani o dialettali; dall'altra alcuni fondamenti di dialettologia, partendo da temi centrali per la tradizione di studi quali le classificazioni e il sostrato fino ad arrivare ad argomenti di confine tra le due discipline, come la commutazione di codice e l'advergenza. Il fine ultimo è sia far apprezzare le potenzialità dell'analisi variazionista su suolo italiano, sia avviare gli studenti, tramite letture guidate, al confronto con la letteratura scientifica, nonché stimolarli alla formulazione di domande di ricerca plausibili.
Programma
Il corso si sviluppa in due moduli strettamente collegati tra di loro. Il primo tenta di definire la disciplina della sociolinguistica della variazione, mettendo a confronto la tradizione di studi americana e quella italiana e passando in rassegna le principali variabili sociali usate per la spiegazione dei fenomeni di variazione e mutamento linguistico. Già in questo primo modulo gli studenti entrano nel vivo delle principali dinamiche della situazione linguistica italiana, grazie all'uso di esempi e letture guidate di testi che descrivono fenomeni propri del nostro contesto nazionale. Poi il corso si sposta verso la dialettologia italiana tramite un ponte tematico relativo alle recenti reinterpretazioni dello "spazio" nell'analisi variazionista, che sono messe in dialogo con alcuni concetti di geolinguistica. Il secondo modulo è costituito da alcune nozioni introduttive di dialettologia, utili a fornire una collocazione precisa a molte delle fenomenologie affrontate nella prima parte del corso. Segue poi un approfondimento su alcuni temi relativi alla stretta compresenza di italiano e dialetti, pertinenti sia alle loro tendenze evolutive, sia all'analisi sincronica del parlato.
Di seguito un temario sintetico del corso:
- Sociolinguistica della variazione vs. Sociologia del linguaggio
- Le origini della sociolinguistica in America e in Italia
- Le variabili sociali e l'identità linguistica
- Lo spazio: dalle isoglosse e le norme areali allo spazio percepito e vissuto
- La dialettologia percettiva: mente, spazio e società sulla mappa
- Dialetti: lingue figlie e lingue sorelle
- Alcune classificazioni dialettali e il problema del sostrato
- Il "bilinguismo" italiano-dialetto: il dialetto come fenomeno di variazione?
- Il cono di Auer: convergenza e advergenza
- La commutazione di codice
Eventuali Propedeuticità
Nessuna
Risultati di Apprendimento (Descrittori di Dublino)
conoscenza e capacità di comprensione: Lo studente dovrà sapersi orientare nel panorama linguistico italiano, riconoscendo le specificità delle lingue coesistenti su suolo nazionale. Dovrà inoltre acquisire conoscenze sulle principali variabili sociolinguistiche e arrivare a comprendere come queste possono contribuire a spiegare le dinamiche sincroniche e diacroniche delle lingue in Italia.
conoscenza e capacità di comprensione applicate: Lo studente dovrà iniziare ad acquisire autonomia nell'applicazione delle idee della disciplina sociolinguistica al panorama linguistico e dialettologico italiano. Dovrà inoltre iniziare ad apprezzare la struttura di un articolo scientifico del settore e le relative differenze rispetto alla produzione manualistica.
autonomia di giudizio: Lo studente dovrà sapere distinguere gli argomenti cardine della sociolinguistica e della dialettologia dai temi ancora oggetto di discussione, al fine di sviluppare un interesse di ricerca autonomo pertinente al settore.
abilità comunicative: Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito la terminologia specialistica dei settori oggetto del corso e di saperla utilizzare in contesti anche inediti rispetto al contenuto dei materiali didattici.
capacità di apprendere: Lo studente sarà avviato alla comprensione delle dinamiche linguistiche di variazione e mutamento, con particolare riferimento all'ambito italiano. Sarà inoltre avviato alla lettura autonoma della letteratura scientifica.
Materiale Didattico
Il materiale didattico predisposto dalla/dal docente in aggiunta ai testi consigliati (come ad esempio diapositive, dispense, esercizi, bibliografia) e le comunicazioni della/del docente specifiche per l'insegnamento sono reperibili all'interno della piattaforma Moodle › blended.uniurb.it
Attività di Supporto
Nessuna.
Modalità Didattiche, Obblighi, Testi di Studio e Modalità di Accertamento
- Modalità didattiche
Lezioni frontali con letture guidate di testi scientifici.
- Obblighi
In accordo con la struttura del calendario didattico, il corso prevede che gli studenti abbiano già frequentato il corso di Linguistica generale I della Prof.ssa Chiara Celata. Un'acquisizione anche solo incipiente delle nozioni spiegate in quel corso è data qui per scontata.
- Testi di studio
Il programma è uguale per frequentanti e non frequentanti. Per dare la possibilità agli studenti non frequentanti di apprendere tramite studio individuale quanto spiegato durante le lezioni, si consiglia vivamente di fare uso delle indicazioni e dei materiali caricati su Blended Learning, utili appunto a raggiungere il livello di preparazione previsto dal corso.
Oltre alle diapositive del corso e ai materiali di studio caricati su Blended Learning, tutti gli studenti sono tenuti a preparare per l'esame i seguenti testi:
- Berruto, G., Cerruti, M. (2019). Manuale di sociolinguistica. Torino: UTET - esclusi § 3.5 (pp. 102-107), § 4.4 (pp. 131-136), §§ 5.1-5.2 (pp. 167-188), §6.3 (pp. 218-236, ma contenente informazioni su VARBRUL e i modelli di regressione, di cui si farà cenno durante il corso a livello puramente teorico).
- Fanciullo, F. (2015). Prima lezione di dialettologia. Bari: Laterza - escluso da §3.2 fino alla fine del volume (pp. 115-162).
- Avolio, F. (2009). Lingue e dialetti d'Italia. Roma: Carocci - da studiare solo il secondo capitolo (pp. 37-59) e i §§ 3.2-3.3 (pp. 67-76).
- Modalità di
accertamento Esame orale (circa 30 minuti).
A ciascun candidato verranno poste tre domande sul contenuto del corso e dei Testi di studio. Laddove possibile, le domande presenteranno esempi dei fenomeni oggetto di studio diversi rispetto a quelli presenti nei Testi, in maniera tale da valutare la capacità di applicazione delle nozioni al di là della semplice memoria. Le risposte alle tre domande dell'esame saranno valutate tenendo conto della conoscenza dei concetti spiegati, della padronanza del linguaggio specifico e della dimostrazione di spirito critico (capacità di ricollegare esempio a concetto e individuazione delle ragioni dietro ai concetti espressi). A ciascuna di queste tre dimensioni il docente attribuirà un giudizio qualitativo su quattro livelli (insufficiente - sufficiente - buono - eccellente). Per passare l'esame con il minimo della valutazione in trentesimi sarà bastevole reagire a due delle tre domande in maniera complessivamente sufficiente.
- Disabilità e DSA
Le studentesse e gli studenti che hanno registrato la certificazione di disabilità o la certificazione di DSA presso l'Ufficio Inclusione e diritto allo studio, possono chiedere di utilizzare le mappe concettuali (per parole chiave) durante la prova di esame.
A tal fine, è necessario inviare le mappe, due settimane prima dell’appello di esame, alla o al docente del corso, che ne verificherà la coerenza con le indicazioni delle linee guida di ateneo e potrà chiederne la modifica.
Informazioni aggiuntive per studentesse e studenti non Frequentanti
- Modalità didattiche
Studio individuale.
- Obblighi
In accordo con la struttura del calendario didattico, il corso prevede che gli studenti abbiano già frequentato il corso di Linguistica generale I della Prof.ssa Chiara Celata. Un'acquisizione anche solo incipiente delle nozioni spiegate in quel corso è data qui per scontata.
- Testi di studio
Il programma è uguale per frequentanti e non frequentanti. Per dare la possibilità agli studenti non frequentanti di apprendere tramite studio individuale quanto spiegato durante le lezioni, si consiglia vivamente di fare uso delle indicazioni e dei materiali caricati su Blended Learning, utili appunto a raggiungere il livello di preparazione previsto dal corso.
Oltre alle diapositive del corso e ai materiali di studio caricati su Blended Learning, tutti gli studenti sono tenuti a preparare per l'esame i seguenti testi:
- Berruto, G., Cerruti, M. (2019). Manuale di sociolinguistica. Torino: UTET - esclusi § 3.5 (pp. 102-107), § 4.4 (pp. 131-136), §§ 5.1-5.2 (pp. 167-188), §6.3 (pp. 218-236, ma contenente informazioni su VARBRUL e i modelli di regressione, di cui si farà cenno durante il corso a livello puramente teorico).
- Fanciullo, F. (2015). Prima lezione di dialettologia. Bari: Laterza - escluso da §3.2 fino alla fine del volume (pp. 115-162).
- Avolio, F. (2009). Lingue e dialetti d'Italia. Roma: Carocci - da studiare solo il secondo capitolo (pp. 37-59) e i §§ 3.2-3.3 (pp. 67-76).
- Modalità di
accertamento Esame orale (circa 30 minuti).
A ciascun candidato verranno poste tre domande sul contenuto del corso e dei Testi di studio. Laddove possibile, le domande presenteranno esempi dei fenomeni oggetto di studio diversi rispetto a quelli presenti nei Testi, in maniera tale da valutare la capacità di applicazione delle nozioni al di là della semplice memoria. Le risposte alle tre domande dell'esame saranno valutate tenendo conto della conoscenza dei concetti spiegati, della padronanza del linguaggio specifico e della dimostrazione di spirito critico (capacità di ricollegare esempio a concetto e individuazione delle ragioni dietro ai concetti espressi). A ciascuna di queste tre dimensioni il docente attribuirà un giudizio qualitativo su quattro livelli (insufficiente - sufficiente - buono - eccellente). Per passare l'esame con il minimo della valutazione in trentesimi sarà bastevole reagire a due delle tre domande in maniera complessivamente sufficiente.
- Disabilità e DSA
Le studentesse e gli studenti che hanno registrato la certificazione di disabilità o la certificazione di DSA presso l'Ufficio Inclusione e diritto allo studio, possono chiedere di utilizzare le mappe concettuali (per parole chiave) durante la prova di esame.
A tal fine, è necessario inviare le mappe, due settimane prima dell’appello di esame, alla o al docente del corso, che ne verificherà la coerenza con le indicazioni delle linee guida di ateneo e potrà chiederne la modifica.
| « torna indietro | Ultimo aggiornamento: 14/06/2025 |