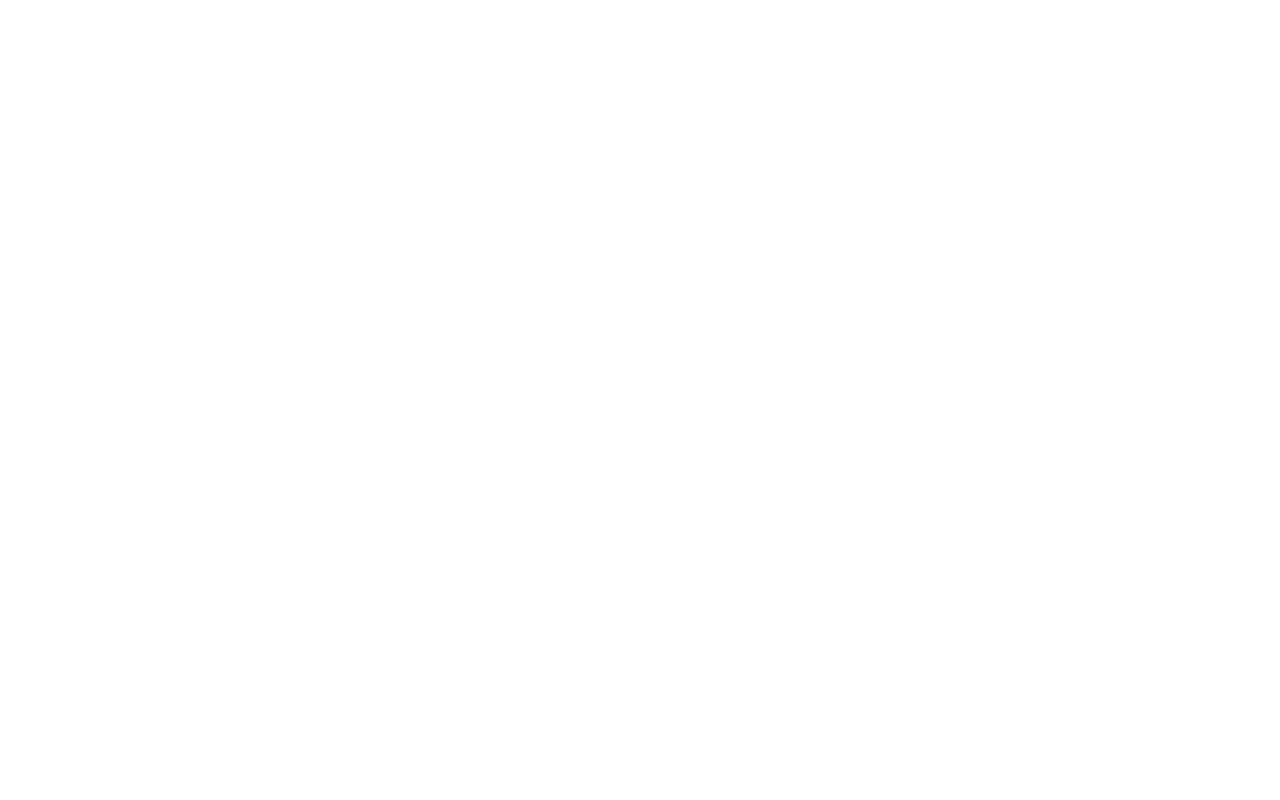GEOMORFOLOGIA E REMOTE SENSING
GEOMORPHOLOGY AND REMOTE SENSING
| A.A. | CFU |
|---|---|
| 2025/2026 | 10 |
| Docente | Ricevimento studentesse e studenti | |
|---|---|---|
| Stefano Morelli |
Assegnato al Corso di Studio
| Giorno | Orario | Aula |
|---|
| Giorno | Orario | Aula |
|---|
Materiale Didattico
Il materiale didattico predisposto dalla/dal docente in aggiunta ai testi consigliati (come ad esempio diapositive, dispense, esercizi, bibliografia) e le comunicazioni della/del docente specifiche per l'insegnamento sono reperibili all'interno della piattaforma Moodle › blended.uniurb.it
| « torna indietro | Ultimo aggiornamento: 20 |